Il coraggio della disperazione
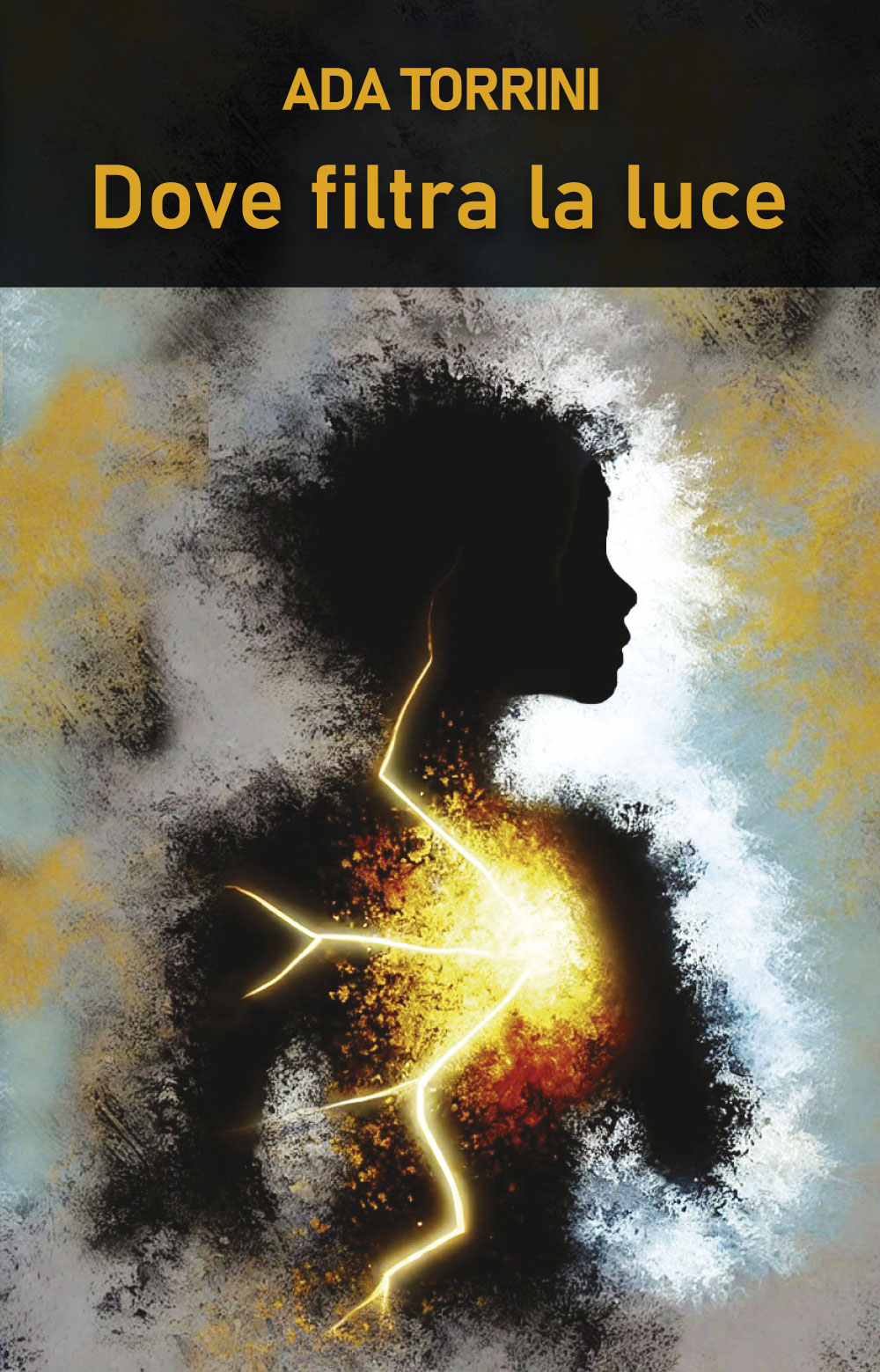
Ogni volta che lo dico, ogni volta che pronuncio quella frase, succede sempre la stessa cosa.
Una nuova arrivata, con cui condivido le stesse ferite.
Presentazioni, scambi, domande e poi la mia voce che dice “Ho denunciato mio padre”.
Silenzio, poi l’inevitabile: “Sei stata coraggiosa!”.
E qualcosa dentro di me si spacca, ogni volta.
Non so come spiegarlo, non è rabbia, non è orgoglio, è più una fitta, un peso.
Perché non ho fatto una cosa coraggiosa, ma una cosa necessaria.
Non era una scelta: era un precipizio.
O cadevo, o saltavo.
E io ho saltato.
Non per virtù, ma per necessità.
Per la nausea di vedere ancora il male respirare libero, di sapere che poteva ancora ferirmi.
C’era la paura che la mia storia diventasse la storia di un’altra bambina, la certezza che non l’avrei sopportato.
E allora ho affrontato quel processo. Per sei lunghi anni.
Non per coraggio — per disperazione.
Il coraggio, forse, è un’altra cosa.
Il coraggio è scegliere quando potresti non farlo.
Il coraggio è un gesto libero.
Io non ero libera.
Ero incatenata, braccata, piena di vergogna che non era mia.
E parlando non ho fatto un atto eroico, ma di sopravvivenza.
Il silenzio mi avrebbe uccisa. Lentamente, ma mi avrebbe uccisa.
Quando dico questo, qualcuna abbassa lo sguardo, qualcuna stringe le labbra.
So che molte non ce l’hanno fatta, non ancora, forse mai.
So che per loro parlare sarebbe come morire di nuovo, e allora scelgono di tacere, come se il silenzio potesse conservare un po’ di pace, un po’ di ossigeno.
Ma non c’è pace nel silenzio.
«I miei silenzi non mi avevano protetta. Il vostro silenzio non vi proteggerà.» diceva Audre Lorde.
Il silenzio non è mai pace, è solo l’ombra del potere.
È la voce dei carnefici che continua a parlare in noi, anche dopo anni, anche quando crediamo di essercene liberate.
È la loro educazione dentro la nostra gola.
“Non dirlo”, dicevano. “Non dire mai niente.”
E noi abbiamo imparato la lezione.
L’abbiamo imparata bene.
Ci hanno cresciute nel rispetto del silenzio, nella devozione del segreto, come fosse un sacramento.
E così il mondo è diventato una chiesa piena di bambine mute.
Ma poi arriva un punto — per alcune arriva, per altre no —
in cui capisci che quel silenzio non è tuo, non lo è mai stato.
È il loro.
È il muro che hanno costruito attorno a sé per continuare indisturbati ad abusare.
È la cappa che la società ha steso sopra tutto, per non vedere, per non sentire, per non sporcarsi le mani.
“Non dirlo.”
“Non farlo sapere.”
“Pensa alla famiglia.”
“Non rovinargli la vita.”
Come se la nostra vita, dopo di loro, non fosse rovinata.
Come se la verità fosse una colpa.
Ma la colpa non è nostra.
La colpa è di chi ha fatto del male.
Di chi ha toccato, mentito, minacciato.
Di chi ha usato il silenzio come arma e lo ha travestito da affetto, da rispetto, da normalità.
E noi, le bambine di allora, siamo cresciute così: con la voce strozzata, la colpa in gola ed il corpo chiuso.
E quando mi dicono “Sei stata coraggiosa!”, io sento solo un dolore profondo, una solitudine che non finisce. Persino insieme a persone che hanno vissuto i miei stessi orrori.
Sento la pena di tutte quelle che non ci sono riuscite, di quelle che non hanno potuto.
Perché vuol dire che siamo poche.
Una su mille, forse.
Una su mille che parla, mentre le altre restano nel buio, strette nella paura, educate al silenzio.
E non le giudico, no.
So cosa vuol dire avere paura.
La capisco, la sento, la riconosco.
So cosa vuol dire quando l’abuso ti entra nella mente, quando la voce del carnefice diventa la tua voce, quando ti convince che non puoi parlare, che nessuno ti crederà, che il mondo ti condannerà.
So cosa vuol dire quando ti insegnano che tacere è l’unico modo per sopravvivere.
Ma a volte mi sento disperata, perché penso che, se restiamo in silenzio, non cambierà mai niente.
Che il mondo continuerà a girare così, tranquillo, con i carnefici liberi e le bambine mute.
Che non basta una su mille.
Che non si cambia il mondo col silenzio degli innocenti.
Perché il silenzio non è solo paura — è educazione.
È cultura.
È sistema.
È la legge invisibile che tiene in piedi il mondo,
quello stesso mondo che non vuole sapere, che non vuole guardare.
E chi decide di spezzare il silenzio, è scomodo.
È meglio dire “È passato”.
Certe cose è meglio non nominarle.
Il silenzio è comodo, educato, civile.
E noi lo chiamiamo “rispetto”, “discrezione”, “famiglia”.
Lo chiamiamo “non voglio rivangare”.
Ma sotto tutti questi nomi c’è solo paura.
E quella paura — trasmessa di madre in figlia, di padre in figlio — è la catena più antica del mondo.
E allora sì, il silenzio è la loro salvezza, non la nostra.
È il loro mantello, la loro tana, il loro ossigeno.
E finché continueremo a tacere, continueranno a vivere tra noi, a sorridere per strada, a dirsi “padri”, “zii”, “nonni”, “amici di famiglia”.
E allora quella frase, “Sei stata coraggiosa!”, diventa una condanna: perché, se serve coraggio per denunciare un padre che ha abusato di te, vuol dire che il mondo è ancora malato, vuol dire che niente è cambiato.
E il virus non è solo nel carnefice.
È nel sistema che lo protegge, nella famiglia che chiude gli occhi, nella società che non vuole vedere, che cambia argomento, che dice “Non esagerare”.
“Non dirlo”, mi diceva mio padre. “Non dirlo mai a nessuno, tua madre ne morirà.”
E io l’ho creduto, per tanto tempo, che, se avessi parlato, il mondo mi sarebbe crollato addosso e sarei rimasta sola.
E allora sì, forse è questo che dobbiamo capire:
che chi tace fa male a tutti.
Non solo a sé stesso, non solo al bambino o alla bambina che è stato.
Fa male all’intera umanità.
Perché tacere non è rimanere fermi, non è neutro, è continuare il movimento del male, solo in un altro modo, più educato, più accettabile.
Tacere è continuare la loro opera, allungargli la vita, garantire loro la prossima vittima.
E allora parlare diventa un gesto collettivo.
Non è coraggio, è responsabilità.
È far parte di qualcosa di più grande, di una comunità che si protegge, che si guarda, che dice “Ti credo” e “Non sei sola”.
È cambiare il mondo. Evolversi.
È dire basta per sé e per chi verrà dopo.
È rompere la catena. Il circolo vizioso.
Quello che voglio è che si guardi la pedofilia in faccia, che si dica, che si scriva, che si urli.
Che la parola diventi scudo, luce, inizio.
E no, non voglio più rispetto, né decenza, né pace.
Voglio la voce, voglio la frattura, voglio lo scandalo di dire tutto.
Voglio che si nomini il male, che si scriva, che si gridi, che si sputi fuori dal corpo e dal tempo.
Non voglio più silenzi, voglio le parole che fanno rumore. Quelle che sporcano, che disturbano, che rompono la tavola della cena e costringono tutti a guardare.
Voglio che la vergogna cambi indirizzo.
Io non sono coraggiosa.
Sono viva.
E finché parlerò, finché qualcuna parlerà,
loro non saranno più liberi di ucciderci.



